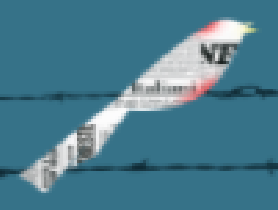Pensare l’impensabile- Jacques Sémelin, avril 2004
traduzione di Laura Fontana, versione originale sul sito www.monde-diplomatique.fr
La ripresa delle ostilità nel Kosovo, alla fine di marzo, sottolinea il fallimento delle “soluzioni” armate.
Dieci anni dopo la tragedia del Ruanda, la responsabilità dell’Occidente, tra cui quella della Francia, resta ancora una volta sottovalutata.
Come si scatena la spirale della violenza che conduce ai massacri?
I ricercatori che lavorano sui genocidi mettono in guardia contro un utilizzo banalizzante del termine e tentano di individuare le caratteristiche comuni di questa forma di guerra contro i civili.
Dall’adozione da parte delle Nazioni unite, il 9 dicembre 1948, della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, questa parola si è fissata nel linguaggio comune per significare il male assoluto, l’orrore estremo che distrugge delle popolazioni civili inermi. Coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, il termine ha incontrato un successo internazionale sempre maggiore. Si è parlato di “genocidio” nel corso del XX secolo in questi termini: la distruzione di popolazioni civili.
Altri termini sono comparsi, come “politicidio” (1988) ou “democidio” (1994). Ma quello di “genocidio” continua a dominare il campo a tal punto che si stanno sviluppando i cosiddetti genocide studies. Ricerche di questo tipo trovano spazio nel nuovo Journal of Genocide Research.
Il primo problema che la parola “genocidio” ci pone si riferisce pertanto ai suoi utilizzi. Il termine appartiene a ogni tipo di retorica identitaria, umanitaria o politica. Il genocidio è un soggetto di ricerca a sé, che rivela tutte le potenzialità e gli sviluppi legati all’uso stesso del termine. La posta in gioco nell’utilizzare il termine è innanzitutto legata alla questione della memoria, per fare riconoscere agli occhi di tutto IL genocidio di cui un popolo sostiene di essere stato vittima nel passato. L’impresa più emblematica in questo campo è quella condotta dalla comunità armena.
Risvolti anche propriamente umanitari, quando delle organizzazioni non governamentali (ONG) dichiarano che un popolo è in pericolo di “genocidio”. L’uso del termine ha per scopo scuotere l’opinione pubblica e in tal modo aprire la strada a un intervento internazionale. Risvolti, ovviamente, anche giudiziari, nel momento stesso in cui il male è stato compiuto e si tratta di perseguire davanti ai tribunali internazionali quei determinati responsabili per “crimine di genocidio”. La nozione può ancora costituire la parola chiave di una retorica molto aggressiva contro un avversario politico. Così, i Serbi del Kosovo hanno dichiarato di essere vittime di un genocidio commesso da parte degli Albanesi fin dalla metà degli anni Ottanta, mentre dei delegati della conferenza di Durban del 2001 hanno accusato Israele di perpetrare un vero e proprio genocidio contro i Palestinesi. Conclusione scontata: il termine serve sia da scudo simbolico, per far valere la propria identità di vittima, sia come spada alzata contro il proprio mortale nemico.
Possiamo sperare in qualche chiarimento da parte dei ricercatori? Non proprio. La gamma di definizioni è vasta, tra lo psicologo Israël Charny, che sostiene che ogni massacro è un genocidio (compreso l’incidente nucleare di Chernobil) e lo storico Stephan Katz, che afferma che solo un genocidio è stato perpetrato nella storia: quello degli Ebrei.
Le opinioni divergono anche al riguardo all’ampiezza di applicazione della definizione data dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Alcuni accettano questa Convenzione del 1948 come base di lavoro, al punto da darne una “traduzione sociologica”, come l’Americana Helen Fein.
D’altro canto, la maggior parte delle opere pionieristiche sul genocidio si aprono ad una discussione attorno a questa Convenzione. Altri studi obiettano che la ricerca sociologica, storica, ecc, non deve essere fondata a priori su un testo giuridico, cioè normativo. Ovvero, intendono sviluppare i genocide studies con gli strumenti di analisi propri delle scienze sociali. Con questo scopo, partono dall’analisi del massacro (come forma di azione, per la maggior parte collettiva, di distruzione di individui non combattenti), chiedendosi in quali circostanze e a quali condizioni un massacro o una serie di massacri possa diventare un genocidio. L’intenzione di distruggere
Un problema tra i tanti: nella definizione di genocidio la Convenzione del 1948 accorda un posto centrale all’ “intenzione di distruggere un gruppo in quanto tale”. Ma la trasposizione in storia di questa nozione è problematica, Alcuni fenomeni catastrofici non sembrano essere stati “voluti”, come la carestia del periodo 1952-1962 nella Cina comunista (tra i 20 e i 43 milioni di morti). Nessuno ha potuto provare fino ad oggi che Mao, nel suo delirio del “Grande Balzo in avanti”, avesse l’intenzione di distruggere il suo popolo. Questa ecatombe è maggiormente dovuta alla rigidità del partito, al suo utopismo volontarista, alla sua incompetenza economica, ecc. D’altro canto, nel caso della carestia in Ucraina negli anni 1932-1933 (da 6 a 7 milioni di morti), la volontà criminale di Stalin è maggiormente identificabile. Nessuno può dubitare che Mosca volesse allora distruggere definitivamente ogni focolaio di resistenza. Si tratta dunque di genocidio? Per alcuni sì; per altri no, nella misura in cui l’intenzione distruttrice di Stalin non era rivolta a eliminare gli Ucraini in quanto tali. Altre popolazioni sono state decimate dalla fame (paesi cosacchi, Kouban, Asia centrale…). Comunque sia la questione, la trappola in cui rischia di cadere perennemente lo storico è quella di trasformarsi in procuratore per provare che tutto era stato calcolato in anticipo, mentre la storia è fatta da un concorso di circostanze, d’incertezze, insomma non è qualcosa di determinato a priori.
Al di là di queste divergenze, i ricercatori condividono tutti la medesima convinzione: quella di pensare che i progressi dei genocide studies presuppongano lo sviluppo delle ricerche comparative. Anche su questo punto, dovremmo rimarcare una mancanza di rigore metodologico quando taluni non esitano a comparare dei casi molto eterogenei. Tuttavia, opere collettive importanti vengono pubblicate da una decina di anni a questa parte e queste opere riuniscono diversi studi di fenomeni.
L’ultimo in ordine di data è quello dei due storici Ben Kiernan e Robert Gellately. Si questo esercizio di comparazione conferma sempre che ogni evento storico è singolare, esso permette anche di sviluppare
degli interrogativi comuni, come ad esempio il passaggio all’atto pratico.
I lavori sulla Shoah servono in tal senso come riferimento, a partire dall’opera miliare di Christopher Browning, “Uomini comuni”. Che si analizzi il caso della Cambogia, del Ruanda o della Bosnia, questo passaggio alla violenza di massa costringe il ricercatore a sollecitare diversi tipi di interpretazioni per sondarne l’enigma.
Bisogna, ad esempio, accordare un peso determinante all’ideologia e, più in senso generale, a un immaginario politico del rifiuto dell’Altro che prepara mentalmente l’atto di massacrare? Sappiamo a tal proposito il ruolo essenziale svolto dagli intellettuali in questa costruzione preliminare di immagini del nemico. Ma questa matrice ideologica, trampolino per l’assassinio di massa, non è mai sufficiente per spiegare il passaggio all’atto. La parte di calcolo nel massacro va altresì presa in considerazione, vale a dire la fredda decisione di massacrare in massa (o di un concatenamento di decisioni) assunta da un numero ristretto di responsabili. Spesso il massacro dipende da una strategia deliberata, al di là che il suo obiettivo finale sia “ripulire il territorio”, conquistare il potere o purificare la razza.
Ma allora, in questo modo non rischiamo di trascurare la dimensione puramente irrazionale del massacro, e più ancora del genocidio, come impresa quasi delirante di costruzione di un ordine rassicurante di unità e di purezza? Dalla psicopatologia all’antropologia, passando per la storia e le scienze politiche, i genocide studies richiamano necessariamente degli approcci interdisciplinari, senza con questo pretendere di poter spiegare tutto.questo pretendere di poter spiegare tutto.
“Il potere assoluto uccide assolutamente”
Un’altra domanda incorre: il genocidio viene commesso dagli Stati forti o dagli Stati deboli? La tesi dello Stato forte sembra imporsi di primo acchito, dal momento che occorre del potere per commettere un massacro e più ancora un genocidio: potere di distruzione, di organizzazione, di propaganda, ecc., come pensa ad esempio Rudolf Rummel : “Il potere assoluto uccide assolutamente”.
Ma questa tesi dello Stato forte è messa in crisi da coloro che attirano l’attenzione sul contesto generale in cui si sono instaurati questi poteri. Essi notano che questi governi, seppur potenti, si ritrovano in posizione di vulnerabilità che è precisamente la condizione che spiega il loro impegno nel massacrare.
Tenere conto del contesto della guerra diventa, in tal senso, essenziale.
In tale contesto, alcuni storici come Philippe Burrin o Christian Gerlach hanno avanzato la tesi che la decisione della “soluzione finale”, assunta dai nazisti probabilmente a partire dal mese di dicembre 1941, non può essere isolata dal fatto che i nazisti prendono tale decisione nel momento in cui si rendono conto di non poter vincere la guerra scatenata contro l’Unione sovietica. E’ pertanto con la coscienza di un fallimento futuro, sentimento rafforzato dall’entrata in guerra degli Stati Uniti dopo il bombardamento di Pearl Harbor (6 dicembre 1941), che Hitler avrebbe assunto la decisione di vincere almeno un altro dei suoi obiettivi fondamentali: lo sterminio degli Ebrei. Un ragionamento abbastanza simile può anche applicarsi al caso degli Armeni, i cui massacri vengono scatenati a seguito di una dura disfatta subita dai Turchi per opera dei Russi, in un contesto di guerra in cui questa minoranza armena dell’Impero ottomano è percepita dal governo dei Giovani Turchi come complice e alleata della Russia. Questo approccio rafforza la tesi di coloro che sostengono che i massacri sono piuttosto il prodotto realizzato da Stati deboli, o che si percepiscono come vulnerabili, o ancora che credono di non poter vincere la guerra senza andare fino alla distruzione delle popolazioni civili.
Promuovere le conoscenze sulle violenze che conducono al massacro, ovvero al genocidio, rappresenta un compito prioritario delle scienze sociali, soprattutto rispetto ad una storia dell’umanità particolarmente pesante in questo contesto. All’inizio del XX secolo, il 10% delle vittime di guerra erano dei civili. Alla fine del XX secolo, il rapporto si è rovesciato: da 80% a 90% delle vittime sono civili.
Un simile sforzo di ricerca comporta anche importanti applicazioni pratiche.
Innanzitutto, nella maniera di pensare il futuro di paesi che hanno vissuto avvenimenti di questo tipo.
Lo scarto tra il discorso di alcuni esperti internazionali che invitano alla “riconciliazione” e la situazione di questi stessi paesi è spesso considerevole, tanto profondi sono i traumatismi che i massacri hanno lasciato nelle popolazioni, da far ritenere inconcepibile la riconciliazione. Cercare di costruire la pace in questi paesi suppone di prendere in conto questa pesante eredità dei traumatismi, piuttosto che negarla proponendo delle soluzioni di “post-conflitto” applicate dall’esterno.
Una riflessione pratica sulla situazione di crisi pre-genocidio si impone in ugual misura: si può prevenire un genocidoo e a quali condizioni? Alcuni teorizzano delle misure di allarme (early warning) che mirino a rivelare le situazioni “pre-genocidarie” e immaginano i mezzi da mettere in atto per soccorrere efficacemente le popolazioni in pericolo. Citiamo, a questo proposito, l’approccio interessante di Gareth Evans e Mohamed Sahnoun. Ma queste proposte di azione preventiva possono rimanere dei meri propositi lodevoli nella misura in cui gli Stati, mossi essenzialmente da interessi egoistici, non manifestino la volontà politica di metterli in pratica.
Per questo, il lavoro delle ONG e dei giornalisti è particolarmente importante, basterebbe il solo fatto di impedire che una tragedia in corso non venga semplicemente cancellata dall’attenzione pubblica internazionale come nel caso della Cecenia. Nello stesso tempo, la pubblica opinione si stanca dei drammi quando gli organi di informazione la tempestano di notizie.
Ed è la ragione per la quale il monito “Mai più!” ricomincia ugualmente: è che purtroppo lo spettro del genocidio non è alle nostre spalle.
Jacques Sémelin, psicologo di formazione, è ricercatore di storia contemporanea presso il centro«Comunicazione e politica» del CNRS. Studioso dell’azione non violenta, si è occupato anche delle modalità di comunicazione dei paesi occidentali con l’Est, e ha diretto la rivista francese «Action Nonviolente». In particolare Sémelin ha dedicato i suoi studi alle strategie di resistenza non armata in opposizione ai regimi totalitari, integrando la tradizionale impostazione di carattere storico con la ricerca dei principi etici e dei meccanismi psicologici che agiscono nelle società impegnate in azioni nonviolente.
E’ autore di Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Le Seuil, Paris, 2005 (tradotto da Einaudi, 2007, Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi).
Il libro, frutto di piú di vent'anni di ricerche e analisi sul tema della violenza, delle sue espressioni estreme, dei suoi usi politici e degli esiti che hanno scandito la storia del XX secolo, si propone di reperire una logica, per quanto atroce e terribile, nell'inferno dei genocidi.
Dirige anche il progetto elettronico di una Enciclopedia on-line delle violenze di massa (Online Encyclopedia of Mass Violence, www.massviolence.org ), lanciata sul web il 3 aprile 2008.