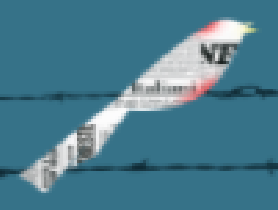Gli ebrei furono vittime della Shoah, un genocidio senza precedenti nella storia, ma non furono passivi di fronte alla persecuzione come comunemente si crede. La storia è ricca di esempi di resilienza e di resistenza durante la Shoah di varia natura e portata, ma le biografie individuali dei sommersi e dei salvati ci raccontano quali e quante strategie di sopravvivenza consentirono agli ebrei perseguitati, attraverso scelte, azioni e comportamenti, di mettersi in salvo, di provare a resistere, di aiutare qualcuno a non morire. Anche nei centri di sterminio che erano concepiti per uccidere e non per internare gli ebrei, ovvero nelle situazioni più disperate e impossibili, ci furono esempi di rivolta.
Oggi vi racconto la storia della rivolta di Sobibòr e di un eroe coraggioso, ma dimenticato a lungo dal suo Paese – l’Unione Sovietica - e dalla storia. Quest’uomo si chiamava Alexander Pečerskij, ma gli amici e famigliari lo chiamavano affettuosamente Sasha. (la foto è di pubblico dominio).
Inannzitutto che cos’era Sobibòr e come funzionavano i centri di sterminio per gli ebrei?
Situato nella Polonia orientale, Sobibòr fu insieme a Belzec e a Treblinka uno dei tre centri della cosiddetta Aktion Reinhardt, il nome in codice che i nazisti diedero al programma di assassinio di massa degli ebrei polacchi del Governatorato generale. Osservando una cartina della Polonia durante la Seconda guerra mondiale, qui nel 1942, si evidenzia dove fu creato il Governatorato per delineare la parte di territorio polacco che fu sottoposta ad un regime di occupazione, a differenza dell’altra zona, situata al confine con la Grande Germania, che fu invece annessa al Reich. Il nome del programma criminale fu dato in memoria di Reinhardt Heydrich, uno dei massimi gerarchi ad
occuparsi del genocidio degli ebrei, dopo la sua morte avvenuta il 4 giugno 1942, a seguito delle |
ferite riportate in un attentato realizzato a Praga dai partigiani cèchi. Cartina geografica che mostra la dislocazione dei tre centri di sterminio di massa per gli ebrei, Belzec, Sobibòr e Treblinka, e il campo di concentramento e di sterminio di Majdanek, situati nel Governatorato generale. Come si vede chiaramente, Auschwitz che funzionò dal 1942 sia come centro di sterminio col gas che come campo di concentramento e di lavoro forzato, si trovava nella porzione di territorio polacco annessa al Reich (chiamata Warthegau), come anche Chelmno, centro di sterminio che funzionava con camion a gas. I tre centri di sterminio funzionavano con camere a gas fisse azionate da monossido di carbonio che veniva immesso attraverso il collegamento dei tubi di scarico di grossi veicoli militari. Sobibòr, Belzec e Treblinka funzionarono dalla primavera del 1942 all’autunno 1943 e complessivamente assassinarono circa 1 milione e 700.000 persone, principalmente ebrei ma tra le vittime si contano alcune migliaia di Sinti e Rom. I centri di sterminio non hanno nulla a che vedere con i campi di concentramento perché non sono concepiti con come campi di prigionia e di lavoro forzato dove occorre alloggiare e organizzare la vita di diverse migliaia di detenuti, ma sono costruiti per l’unica funzione che devono svolgere: l’assassinio rapido e di massa degli ebrei che appena scendono dai treni con cui vengono deportati, quasi sempre treni merci dove sono ammassati in condizioni disumane, senza cibo, acqua e servizi igienici, sono costretti a spogliarsi, a entrare nelle camere a gas e dopo una morte atroce per asfissia, i loro corpi vengono seppelliti in grandi fosse comuni, anche se in un secondo tempo i nazisti decideranno di riesumare i corpi e di bruciarli all’aperto per ragioni di ordine pratico. |
Veniva però fatta temporaneamente una sola eccezione, perché anche in un luogo concepito come una catena di montaggio di uccisione serviva del personale a cui affidare certi compiti. Solo poche centinaia di uomini e di donne adulti (complessivamente 600) venivano tenuti in vita come Arbeitsjuden (ebrei da lavoro) per lo stretto tempo necessario che occorreva per occuparsi di smistare i vestiti e gli oggetti delle vittime, per piccoli compiti di manutenzione nel campo, rinforzare le recinzioni, riparare qualcosa, cucire qualcosa per le guardie, ma soprattutto per il lavoro più sporco che consisteva nella gestione dei cadaveri che dovevano essere fatti sparire affinché del crimine non ci fosse alcuna traccia visibile. Questi prigionieri non vivevano a lungo perché nel giro di qualche giorno o settimana venivano uccisi come tutti gli altri affinché non potessero testimoniare e quindi erano sostituiti con altri deportati scelti tra gli ultimi arrivati.
Da questi centri di morte non era possibile uscire vivi perché non era contemplata la sopravvivenza oltre pochi giorni.
Ma qualcuno sopravvisse e ha testimoniato. Qualcuno è addirittura riuscito a scappare da un inferno blindato che era costruito per la distruzione totale delle sue vittime.
Nell’estate 1943, arrivano sempre meno treni di ebrei e questo, per i pochi superstiti nel campo, è un cattivo segnale, perché significa che di lì a poco i nazisti avrebbero terminato il massacro e chiuso definitivamente Sobibòr. Il timore prende forma soprattutto quando viene liquidato il centro di Belzec e i pochi sopravvissuti vengono trasferiti a Sobibòr dove alcuni riescono a raccontare ai compagni notizie terrificanti.
In quel momento, presentendo che la fine è imminente, una decina di prigionieri ebrei polacchi che facevano parte degli Arbeitsjuden si raggruppano attorno a Leon (Lejb) Feldhendler e si mettono d’accordo per tentare la fuga. Il progetto era però così pericoloso e altamente a rischio che decidono di non farne parola neanche con gli altri compagni per paura di essere traditi.
Ma come tentare una fuga di gruppo da un luogo così blindato, peraltro situato in Polonia, dove gran parte della popolazione è ostile agli ebrei o ha paura di ritorsioni? Va ricordato che in Polonia vigeva la legge marziale, cioè la fucilazione o impiccagione di tutta la famiglia qualora venisse scoperto uno dei suoi membri a proteggere i perseguitati.
Il tentativo di scavare un tunnel sotterraneo effettuato dagli ebrei che si trovavano rinchiusi nella parte di Sobibòr dove c’erano le camere a gas e che dovevano lavorare a stretto contatto coi cadaveri era fallito, le SS avevano scoperto il piano e avevano trucidato tutti gli internati del gruppo.
Gli ebrei polacchi, per la maggior parte, non hanno alcuna esperienza militare, non hanno armi né sanno usarle. Feldhendler, in particolare, è figlio di un rabbino, ha scarsa propensione per il combattimento.
La speranza di potercela fare sembra arrivare il 22 settembre, quando a Sobibòr arriva un convoglio con 2000 ebrei provenienti da Minsk, tra cui diversi soldati russi. Tra loro c’è il luogotenente dell’Armata Rossa Alexander Pečerskij, detto Sasha, nativo di Kremenčuk in Ucraina.
Alexander è un uomo di 34 anni abituato a combattere e a resistere. Fatto prigioniero in
guerra nell’ottobre 1941, Sasha ha conosciuto diversi campi di prigionia, ha già un tentativo di evasione alle spalle, quindi può essere considerato un veterano della sopravvivenza nei lager.
Giunto a Sobibòr l’ufficiale si salva dalla morte immediata, con altri 79 uomini di quel trasporto, perché mente alla richiesta delle SS che chiedono ai deportati chi di loro sappia svolgere il lavoro di falegname, dichiarandosi specializzato per quel compito.
Subito la notorietà di Pečerskij arriva alle orecchie del piccolo gruppo di resistenza clandestina del campo. Feldhendler non esita a chiedergli aiuto, assistito da un compagno che traduce la sua richiesta dallo yiddish, per progettare con loro la fuga e guidare la rivolta. Sasha accetta subito perché capisce che a Sobibòr non c’è scampo per nessuno e impiegherà solo 3 settimane per portare a termine il suo incredibile piano.
Il progetto della fuga prevede di attirare alle 4 del pomeriggio, quando i turni di lavoro giungono al termine, le guardie SS e gli ausiliari ucraini adibiti alla sorveglianza in luoghi appartati per ucciderle senza dare nell’occhio, impossessarsi delle loro pistole e poi accedere al deposito di armi che sarebbero state distribuite ai ribelli. All’appello serale, un segnale avrebbe dato inizio alla fuga, sparando prima alle guardie, abbattendo la recinzione e fuggendo nei fitti boschi della zona, dove sarebbe stato facile far perdere le proprie tracce.
Occorre sapere che il numero delle guardie in un centro di sterminio era molto basso proprio perché erano pochi i prigionieri tenuti in vita che necessitavano di essere sorvegliati. A Sobibòr erano in servizio una ventina di SS e un centinaio di guardie ucraine che erano prigionieri di guerra russi che in cambio della vita avevano accettato di collaborare coi nazisti, erano stati addestrati appositamente per lavorare in un centro di sterminio ed erano chiamati Trawniki, dal nome del campo di addestramento.
In realtà, Pečerskij è ben cosciente che il piano sia folle e che non sia possibile a tutti di scappare, tuttavia quello che lo motiva ad agire - lo dirà poi nella sua testimonianza rilasciata anni dopo la fine della guerra – è la consapevolezza che nulla sia peggio che rimanere a Sobibòr, quindi che il tentativo disperato valga la pena solo nella speranza di poter salvare almeno qualcuno tra i fuggiaschi e poter testimoniare al mondo quell’orrore.
L’azione prende forma il 14 ottobre 1943 alle ore 16. Il giorno viene scelto perché il comandante ed altre due SS non sono in servizio al campo. In meno di un’ora vengono uccise con armi improvvisate undici SS, ma la scoperta del cadavere di una di esse fa immediatamente scattare l’allarme delle altre guardie che accorrono e reagiscono prima che i prigionieri riescano ad impadronirsi del deposito di armi. Essendo scoperti, quasi tutti disarmati e senza un piano alternativo, i ribelli tentano il tutto e per tutto e si precipitano in massa verso le recinzioni, abbattono il cancello di ingresso e calpestandosi gli uni sopra gli altri, si danno disperatamente alla fuga. Nel caos e nel terrore generale, sono in 600 a darsi alla fuga, non solo il gruppo organizzato per la rivolta, in pratica la maggioranza dei prigionieri rimasti in vita a Sobibor. Un piccolo gruppo di 130 prigionieri opta invece per la passività, rinunciando a scappare sia perché sono troppo malati e sfiniti per correre, sia perché sperano di essere risparmiati dalla furia tedesca. Verranno tutti giustiziati il giorno seguente.
Dei fuggiaschi, una buona parte viene uccisa dai colpi di arma da fuoco sparati dalle guardie ucraine e dalle SS, soprattutto dalle mitragliatrici delle torrette, molti altri cadono sul terreno minato che circonda Sobibòr. I tedeschi, infatti, avevano segretamente minato l’area limitrofa a Sobibòr dopo aver ricevuto la notizia di un tentativo di fuga da Treblinka nell’agosto precedente. I prigionieri lo ignoravano e molti morirono saltando in aria su una mina. In tutto riescono ad uscire
dal cancello del campo e ad avviarsi verso i boschi circa 300 prigionieri, principalmente uomini ma anche alcune donne, ma 70 vengono subito uccisi nella fuga e circa 170 sono catturati nei giorni immediatamente successivi, oppure vengono riconsegnati dalla popolazione locale.
Tra i fuggiaschi ci sono ragazzi giovanissimi, appena adolescenti come Fiszel Bialowitz, di 14 anni, e Thomas (Toivi) Blatt, di 16, entrambi polacchi. Erano stati risparmiati per occuparsi di vari lavori come rinforzare la recinzione attorno al campo e ispezionare i vestiti delle vittime alla ricerca di oggetti preziosi. Josef Cuckierman è ancora più piccolo coi suoi 13 anni ed era addetto alle cucine come tuttofare.
Ci sono anche due giovani, Selma Wijnberg e Chaim Engel, lei olandese, lui polacco, che si sono conosciuti e innamorati proprio a Sobibòr, riusciranno entrambi a sopravvivere e dopo la guerra si sposeranno e fonderanno una famiglia con dei figli.
Il numero esatto dei sopravvissuti alla rivolta e alla fuga non è noto ma si stima siano meno di 50, forse 47.
Dopo la rivolta, Sobibòr cessa la sua attività e viene smantellato. Come per Belzec e Treblinka, i nazisti cercarono di cancellare completamente le prove dei crimini che avevano commesso, distruggendo le camere a gas e i documenti del centro di sterminio, bruciando completamente i corpi e rivoltano la terra sull’area dove era stato costruito il campo, piantandoci sopra alberi e piante affinché nulla fosse visibile di quanto era accaduto.
Il cartello segnale della stazione di Sobibòr coi binari ferroviari, fotografia degli anni 2000, pubblico dominio.
Tra coloro che rimangono in vita c’è anche l’eroe ucraino, il tenente Pečerskij che continuerà la sua guerra contro i tedeschi, unendosi ad un gruppo di partigiani sovietici fino a quando non verrà gravemente ferito ad una gamba. Alla fine della guerra, Sasha rimpatria in URSS ma invece di accoglienza e onore per aver combattuto quattro anni contro i nazisti, avrà una vita molto difficile, come tutti i reduci militari sovietici sui quali pesa il sospetto che si siano arresti e consegnati al nemico senza combattere fino alla morte.
Chiamato a testimoniare al Processo di Norimberga, gli viene vietato da Mosca di recarsi in Germania. Come tutti i sovietici che erano stati fatti prigionieri di guerra dai tedeschi ed erano stati imprigionati nei lager, anche Pečerskij viene trattato con grande durezza per il timore che abbia tradito il suo Paese, umiliando la forza patriottica della grande Russia. Non ottiene, dunque, alcun riconoscimento per l’eroica rivolta da Sobibòr, anche perché il regime sovietico non vuole sottolineare il ruolo degli ebrei nelle imprese di combattimento contro i nazisti, né vuole evidenziarli come vittime specifiche dei crimini perpetrati dalla Germania di Hitler. Inoltre, a differenza di Majdanek dove nel luglio 1944 era arrivata l’Armata Rossa che, pur trovando il campo
semi abbandonato, aveva potuto documentare quella “liberazione” e mostrare le prove delle atrocità commesse dai nazisti, Sobibòr era stato completamente distrutto dagli stessi nazisti, azzerando per gli alleati sovietici la possibilità di “scoprirlo” e di “liberarlo”.
In altre parole, ricordare la rivolta e la fuga di Sobibòr era considerato allora un fatto troppo legato agli ebrei che rischiava di mettere in secondo piano la tragedia dei russi come vittime del nazismo.
Nel 1948 Alexander Pečerskij viene deportato col fratello in un GULag in Siberia. Mentre il fratello muore per le conseguenze del diabete e delle privazioni, Sasha sopravvive fino al 1953 quando viene liberato, grazie soprattutto alle numerose pressioni internazionali e alle petizioni dei superstiti di Sobibòr che testimoniano in suo favore.
Sasha, l’eroe di Sobibòr che capeggiò l’unica rivolta in un centro di sterminio che ebbe (parzialmente) successo, muore nella sua amata Russia nel gennaio 1990, a Rostov sul Don dove oggi è stata eretta una targa in sua memoria.
Alexander Pečerskij in Russia qualche anno prima della sua morte. Foto di pubblico dominio
Il ruolo coraggioso svolto da Pečerskij - ma accanto a lui non va dimenticato Leon Felhender che viene ucciso alla fine della guerra a Cracovia, nel 1945, da un antisemita polacco, esponente della destra estremista polacca – cade nell’oblio per decenni e le sue imprese sono note solo ai piccoli ambiti accademici che studiano la Shoah. Il grande pubblico ha scoperto la storia della straordinaria rivolta di Sobibòr grazie al film hollywoodiano per la TV intitolato Fuga da Sobibòr, diretto da Jack Gold e diffuso nel 1987. Il governo di Mosca negò ad Alexander il permesso di partecipare alla prima del film.
A questo grande esempio di resistenza ebraica nella Shoah sono stati successivamente dedicati altri film, tra cui il documentario del 2001 del regista francese Claude Lanzmann (Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures), e la produzione russa del 2018, diretta da Konstantin Khabenskiy.
Italia